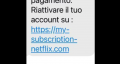Doveva essere l’erede di Sex and the City, almeno nelle intenzioni, la nuova creatura di Darren Star per la generazione successiva a quella cresciuta con Carrie & Co., ma Emily in Paris è poco più che una confezione di lusso per un prodotto appena ordinario.
Nonostante l’enorme budget impiegato per la produzione – la serie è interamente girata a Parigi e questo è indubbiamente un punto forte, le location sono tutte prestigiose, i costumi eccezionali, la cura dei dettagli impeccabile – la sensazione è che manchi la sostanza vera, e cioè una scrittura forte, originale, che scavi un po’ sotto la superficie così patinata e perfetta con cui Emily in Paris si offre al pubblico in ogni episodio, perfino in ogni scena.
Il forte impatto visivo di una Parigi avvolgente, sensuale, tanto tirata a lucido da sembrare una cartolina, e l’immagine deliziosa di Lily Collins, che della serie è anche produttrice, non bastano a rendere Emily in Paris qualcosa di più di un esercizio di stile.
Innanzitutto perché, nonostante la trama coinvolga degli adulti in un ambiente altolocato, è sviluppato come un teen drama, con amorazzi vari conditi da panorami mozzafiato e schermaglie lavorative che quasi sempre si risolvono con qualche guizzo della protagonista. E qui arriva il problema vero: non c’è profondità nella trama e nei personaggi di Emily in Paris (anche se questi ultimi hanno comunque una naturale evoluzione nel corso dei dieci episodi) e l’intera serie si presenta come un concentrato di stereotipi abusati e stantii, tanto sui francesi quanto sugli americani.
Per carità, magari i luoghi comuni non sono tutti infondati – che i francesi possano essere un popolo un po’ escludente su alcuni aspetti, dalla lingua al rispetto delle loro tradizioni, non è del tutto falso – ma restano comunque degli stereotipi e nulla più. I palazzi senza ascensore né acqua calda, che restano senza corrente e scricchiolano come se dovessero crollare da un momento all’altro, sono davvero sinonimo di una rappresentazione falsata e trita delle Capitali europee. Lo erano già in Mangia, Prega, Ama, dieci anni fa, quando Julia Roberts viaggiava incantata tra cartoline antiquate del Belpaese, figurarsi se non lo sono ora. Tutta la serie si gioca sul dualismo francesi-americani, nel lavoro, nelle relazioni, nella concezione della donna e dei rapporti tra i sessi, nell’idea di cosa sia il lusso e come vada comunicato. Peccato che in Emily in Paris i francesi ne escano come antipatici, lussuriosi, presuntuosi e attaccati alle loro abitudini lassiste e antiquate, mentre gli americani di cui la protagonista è l’unica rappresentante come un pesce fuor d’acqua in quel di Parigi ne escano come i progressisti già proiettati nel futuro, fedeli al mito della produttività, unici depositari di una visione corretta e socialmente accettabile dei diritti delle donne e dell’etica del lavoro.
La trama in sé – una giovane direttrice marketing inviata a Parigi per portare una visione “americana” nella comunicazione di un’agenzia vecchio stampo appena acquisita dalla sua società – risulta estremamente prevedibile nelle sue evoluzioni: non c’è nulla di particolarmente sorprendente per lo spettatore, a partire dall’addio al fidanzato di Chicago passando per la storia d’amore col vicino di casa, dal triangolo amoroso con la fidanzata di quest’ultimo alle avventure di letto più o meno casuali in cui incorre la protagonista, scimmiottando le ragazze di Sex and the City.

Alla fine della fiera in Emily in Paris tutto si regge sull’estetica perfetta delle immagini, ma a voler scavare un po’ più a fondo si trova davvero poca materia interessante: i personaggi sono perlopiù caricaturali, quelli francesi in particolare sono quasi delle macchiette, e anche i temi affrontati – pur importanti come le molestie sul luogo di lavoro, il mobbing, il MeToo – sono trattati superficialmente. Ad esempio, c’è davvero bisogno che un’americana spieghi a due francesi di mezza età che una donna che cammina nuda su un ponte per pubblicizzare un profumo rende una pubblicità sessista e non surrealista? E davvero si può banalizzare la professionalità di chi lavora nel marketing e nei social media ritraendo la protagonista come un’esperta di social media che dalla sera alla mattina diventa un’influencer suo malgrado? Emily in Paris ripropone tutta la superficialità che circonda i lavoratori della comunicazione e del digitale, fornendo un’idea distorta di come funziona il marketing e di cosa sono le strategie per i social media e facendo sembrare sufficiente aprire un profilo Instagram per lavorare con successo nel settore. Come se si potesse diventare Chiara Ferragni nel giro di qualche mese solo aprendo un account Instagram e creando qualche contenuto coinvolgente (ottima però la trovata di identificare l’account della protagonista col titolo della serie, anche questo è marketing!).
Tutta la serie è permeata da un’idea decadente della cultura europea – e francese nello specifico – di fronte alla quale l’americano medio si sente avanti anni luce. Ma anche la protagonista è giudicata con riserva dai francesi perché la sua è considerata una mentalità semplicistica e riduttiva, mentre l’esuberanza con cui si pone è considerata (in maniera assolutamente poco credibile) rude e volgare. E questo confronto sterile tra culture, oltre che l’esemplificazione di uno stereotipo, è anche un po’ offensiva da ambo le parti.
Darren Star poteva e doveva fare di meglio: il risultato è che Emily in Paris è una commedia fin troppo leggera, un packaging scintillante per un’insalatona di cliché che non lascia altro segno se non regalare immagini di una Parigi incantevole.
- Il nostro dispositivo per lo streaming più potente, con un’antenna...
- Avvia e controlla la riproduzione di film e serie TV con il...